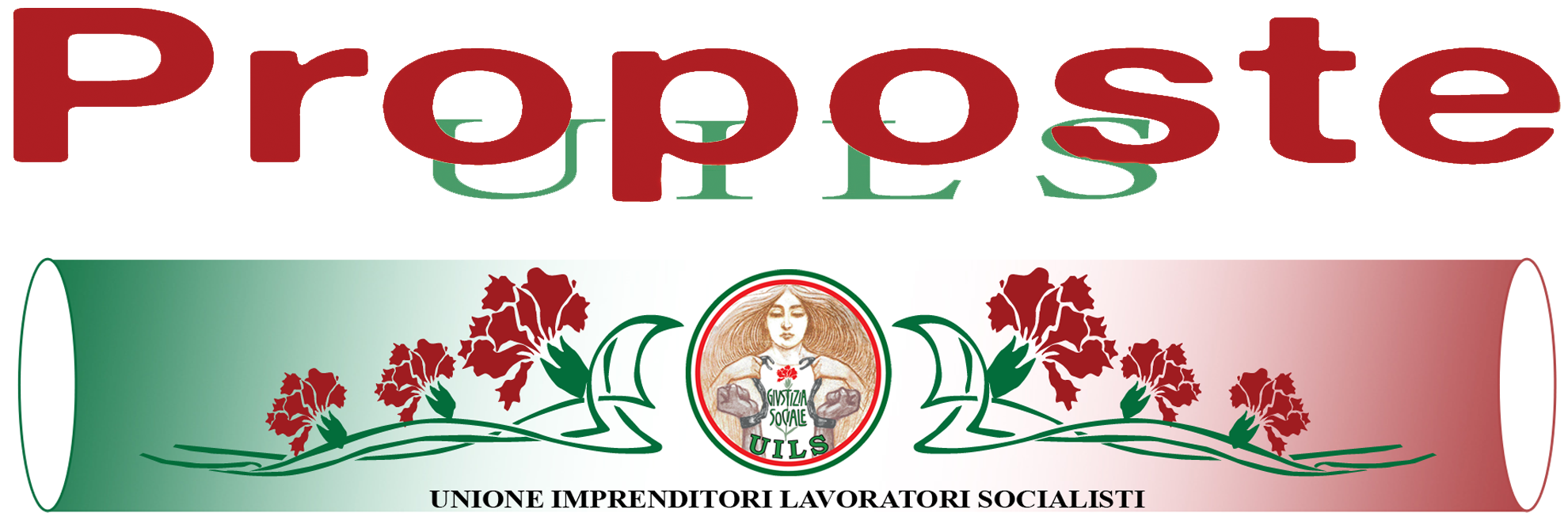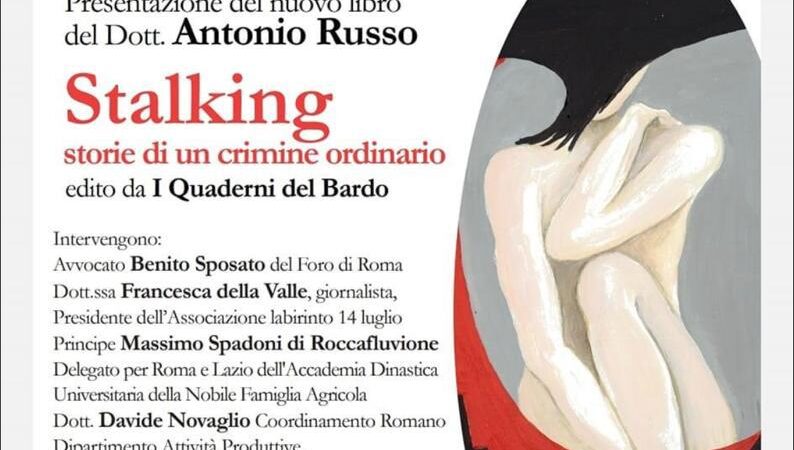Il cimitero dei vivi: l’emergenza inarrestabile dei suicidi nelle carceri italiane

L’estate appena trascorsa ha registrato un drammatico aumento dei casi di suicidio nelle carceri italiane fino a raggiungere il triste record di 15 suicidi nel solo mese di agosto
Nonostante l’emanazione di norme specifiche per la prevenzione del suicidio nelle carceri a tutti i livelli dell’ordinamento nazionale ed anche sovranazionale ci troviamo ad affrontare numeri e dati sconcertanti
Il raffronto tra i dati forniti dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti nella Relazione al Parlamento 2022 e quelli forniti dall’Associazione Antigone Onlus nel suo Dossier sui suicidi in carcere nel 2022 restituisce un quadro impietoso del fenomeno suicidario nelle carceri italiane.
L’Appendice alla Relazione, nel suo “Focus suicidi” relativo al 2021, riporta un numero di casi pari a 59, di cui ben 13 erano persone in attesa del primo grado di giudizio.
Il Dossier d’altro canto, documenta un’accelerazione: con 59 casi di suicidio accertati in riferimento ai primi otto mesi del 2022 è stato raggiunto con largo anticipo il totale dei casi del 2021. Trentaquattro di essi riguardavano peraltro detenuti sottoposti a misura cautelare. Ai suicidi devono aggiungersi anche i 1.078 tentativi sventati nel corso del 2022. Tali tentativi concorrono a tratteggiare i contorni di un fallimento conclamato che non accenna a migliorare tenuto conto che nel 2021 il c.d. Tasso di incidenza è stato in linea con la crescita registrata nei quattro anni precedenti, e che attualmente il numero dei suicidi che avvengono in carcere è 16 volte più alto rispetto alla società esterna.
Il progresso degli studi medici e criminologici in campo penitenziario ha consentito di individuare i fattori che possono contribuire ad innalzare il rischio suicidario tra i ristretti. Essi sono stati ravvisati soprattutto nel momento che precede e in quello che segue il passaggio in giudicato della sentenza; nella carcerazione in attesa di giudizio; nel momento che precede o segue il trasferimento da un Istituto ad un altro; nell’avvicinarsi del fine pena; nel sovraffollamento; nelle difficoltà nell’usufruire degli elementi del trattamento rieducativo e nel mancato godimento di diritti e benefici; nelle scarse possibilità di lavoro; nella sistemazione in cella singola.
Sulla base di queste conoscenze già la Risoluzione “Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners” adottata dall’ONU il 30 agosto 1955 poneva in evidenza la necessità di integrare il personale degli istituti penitenziari con un numero sufficiente di specialisti, psichiatri, psicologi, assistenti sociali e criminologi clinici.
Anche il nostro Paese adeguandosi ha introdotto norme dirette al contrasto del suicidio nelle carceri. In particolare, la Riforma dell’Ordinamento penitenziario del 1975 ed il successivo Regolamento attuativo disciplinano istituti innovativi come il c.d. colloquio di primo ingresso per verificare la capacità individuale di affrontare lo stato di restrizione, al quale si affianca il c.d. presidio psicologico, che si rivolge agli imputati in stato di custodia cautelare ed ai detenuti ed internati provenienti dalla libertà. Con la Circolare del 30 dicembre 1987 n. 3233/5683 è stato istituito il “Servizio nuovi giunti”, che si attiva nei confronti di tutti i detenuti al momento del primo ingresso in istituto.
In tempi recenti, la prevenzione specifica del rischio autolesivo è stata affrontata con Circolari del DAP ad hoc, e con l’adozione nel 2017 del “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” il quale ha delineato un particolare modello di intervento delle istituzioni sanitarie e penitenziarie nell’elaborazione del profilo suicidario e nella prevenzione del rischio.
Tuttavia, vi è uno scarto tra le prescrizioni della legge e la loro attuazione. Una delle cause principali risiede nel fatto che le figure investite del compito di prevenire il suicidio all’interno delle carceri sono presenti in un numero assai inferiore all’organico previsto.
Il carcere è stato definito il «grande assente» della campagna elettorale
Viene denunciata la carenza strutturale di personale di polizia penitenziaria – gli operatori maggiormente a contatto con i detenuti-, l’inadeguata copertura dei ruoli di Direttore penitenziario, educatore e psicologo, nonché l’inadeguata presenza di medici di base. A ciò si aggiunge l’insufficienza dello strumento “principe” nel trattamento dei detenuti: il lavoro e la formazione professionale.
Negli ultimi mesi dell’anno sono state assunte nuove unità destinate a sopperire al turnover dell’area tratta mentale, nonostante ciò, la persistente penuria di personale che svolge una funzione di controllo, di aiuto e di confronto col mondo esterno deve essere annoverata tra le principali cause dell’incremento del tasso di incidenza suicidaria riscontrato negli ultimi cinque anni.
Potrebbe apparire retorico concludere che i detenuti siano abbandonati a se stessi in un sistema nel quale l’elemento morale ed umano è stato soppiantato da un criterio di efficienza tecnico-burocratica, ma il fatto che la Magistratura di sorveglianza sia stata esclusa dalla riforma dell’Ufficio del processo nella Riforma della giustizia penale depone decisamente a favore di questa ipotesi, dal momento che il complesso dei diritti riconosciuti ai detenuti manca di strumenti efficaci per la loro concreta attuazione.
Alla luce di quanto esposto risuonano di scottante attualità le parole pronunciate dal leader socialista Filippo Turati alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904, nello storico discorso conosciuto come “Il cimitero dei vivi”: “[…] noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice […]”.