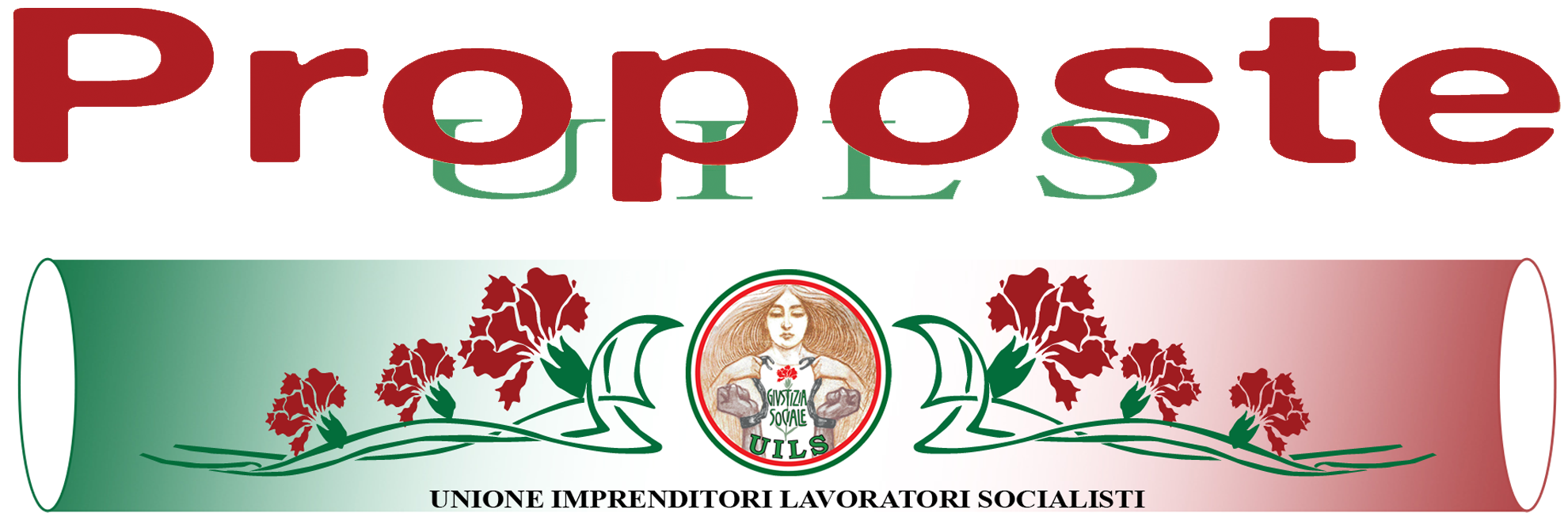Soluzioni per il Medio Oriente? Sì, ma Non Dalla Guerra

| Educazione alla pace tra Italia e Giordania |

Tra Iraq, Arabia Saudita, Siria e Israele, la Giordania diventa rifugio, crocevia ed incontro
Da anni il Medio Oriente è scenario di conflitti che non accennano a terminare, e in mezzo a questi fuochi c’è la Giordania, luogo sicuro per profughi di Paesi limitrofi e per Non Dalla Guerra, associazione di promozione sociale di cui Davide Travaglini, intervistato di quest’articolo, è portavoce.
Ciao Davide, innanzitutto ti chiedo com’è nata NDG e di cosa si occupa.
È nata nel 2016 dopo un viaggio in Giordania di due ragazzi vicentini che, avendo visto la realtà dell’accoglienza dei profughi siriani o iracheni, hanno iniziato a proporre un’esperienza di incontro in Giordania rivolta ad altri giovani. Da questo viaggio è emersa la necessità di parlare soprattutto a loro, da qui il motivo degli interventi nelle scuole. Oltre alle attività in Giordania e negli istituti, nel 2020 abbiamo attivato la campagna “Vicini di banco” con lo scopo di supportare l’educazione di minori siriani, iracheni o giordani in situazioni di vulnerabilità: crediamo infatti nell’importanza dell’educazione come mezzo per migliorare la propria situazione e costruire un futuro privo di violenze.
A proposito di laboratori, nelle scuole fate un’attività interattiva legata alla riproduzione di suoni. Di cosa si tratta?
Sono Silent Lab o Silent Play, esperimenti con cuffie wireless il cui nome deriva dal marchio registrato della compagnia teatrale vicentina “La Piccionaia”, con cui abbiamo iniziato questo lavoro nella figura di Carlo Presotto. Questi laboratori servono a sviluppare una sorta di empatia: ci sono tracce riguardanti persone che devono lasciare la propria casa e che ci chiedono di riflettere su noi e l’altro.
Spesso sentiamo parlare di Palestina, Siria e Israele, ma non molto di Giordania: come la descriveresti?
Credo non venga nominata perché da anni è l’unico Stato del Medio Oriente a non aver avuto un conflitto direttamente in casa. C’è una monarchia parlamentare supportata dalla popolazione: per esempio, durante le primavere arabe il re ha cercato di venire incontro alle richieste con alcune riforme. Oggi sono circa 3 milioni i rifugiati nel Paese, sugli 11 milioni di popolazione totale, la cui maggioranza è di origine palestinese” . È un Paese prevalentemente desertico dove la mancanza di acqua è un tema centrale; l’economia si fonda su siti turistici come Petra, ma ha accusato il drastico calo di visitatori negli anni più caldi del conflitto siriano.
Potresti riassumere gli ultimi dieci anni in Siria, in relazione alla Giordania?
Dagli anni ’70 la Siria è governata dalla famiglia Assad, parte di una minoranza sciita che ha governato attraverso uno stretto controllo politico-sociale, reprimendo le opposizioni e discriminando la maggioranza (sunnita) della popolazione. La crisi attuale è scoppiata nel 2011 con le primavere arabe, a cui l’esercito ha risposto in maniera radicale, reprimendo con la forza manifestazioni nate come pacifiche. Da quel momento è iniziata un’escalation di violenza che ha portato alla nascita dell’attuale guerra civile che vede lo scontro tra le forze governative e i ribelli: un contesto estremamente complesso nel quale dal 2014 si sono inserite anche le milizie legate anche all’ISIS. Nei primi anni le persone volevano restare in Siria con la speranza di cambiare le cose, poi hanno cominciato a spostarsi. In Giordania, la lingua araba e la maggioranza sunnita hanno generato vicinanza con i siriani, che hanno raggiunto il paese nella speranza di poter un giorno tornare nel loro paese. Gli iracheni invece, prevalentemente cristiani, hanno raggiunto la Giordania in attesa di un visto per raggiungere gli Stati Uniti, l’Australia o il Canada. Ora i siriani con cui abbiamo parlato ci hanno raccontato la loro idea di rimanere: forse per via di una cristallizzazione della situazione, con i curdi a nord minacciati, la città di Idlib in mano a ribelli aiutati dalla Turchia e la maggior parte del Paese che è tornata nelle mani di Bashar al-Assad. Proprio per questo motivo il nostro focus è da anni l’educazione: queste realtà soffrono e vengono aiutate nell’emergenza immediata, ma le crisi che subiscono possono durare decenni e per questo è importante guardare al lungo periodo e al bisogno delle persone di ricominciare.
Nel vostro Manifesto si legge: “Siamo preoccupati per il sorgere di governi antiliberali e populisti. Li vediamo come un risultato di problemi strutturali e come conseguenza di una crisi di valori”. Come pensi stia operando la politica italiana rispetto al Medio Oriente?
Come associazione che crede nel diritto di viaggiare, abbiamo cercato di denunciare l’ampio piano europeo per il contenimento dei flussi migratori attraverso l’esternalizzazione delle frontiere. È un problema che interessa il Medio Oriente, ma che ci riguarda da vicino per quanto concerne le rotte nel Mediterraneo centrale: gli accordi Italia-Libia, rinnovati tacitamente anche quest’anno, ne sono un esempio. In senso più ampio, da anni siamo abituati a sentire slogan semplicistici in risposta a problemi estremamente complessi: la migrazione è gestita come un’emergenza, ma un’emergenza dura 5 anni al massimo, dopodiché diventa un fenomeno strutturale e sistemico che va capito e affrontato con il giusto approccio.
Sempre dal Manifesto: “NDG significa che non esiste risposta o soluzione che venga dalla guerra”. Come caleresti questa frase in questo o altri conflitti?
Da anni nel nostro lessico è centrale la guerra, il difendersi da qualcosa. Nelle scuole diciamo che la pace è spesso considerata un’utopia, ma “pace” non è bandiere arcobaleno e gessetti colorati, è qualcosa di concreto: è capire che l’industria delle armi crea disuguaglianze, che quello che faccio nel mio quotidiano ha delle ripercussioni. Da un anno a questa parte, la guerra che come italiani abbiamo in mente è quella in Ucraina, ma al mondo ci sono oltre 60 conflitti di cui non sentiamo parlare. Dobbiamo chiederci che ruolo abbiamo noi e che ruolo ha l’Italia, la cui industria bellica vende armi ai Paesi in guerra o Paesi limitrofi che le recapitano: ciò crea instabilità, quindi poi non possiamo stupirci se le persone di quei posti cercano rifugio altrove.